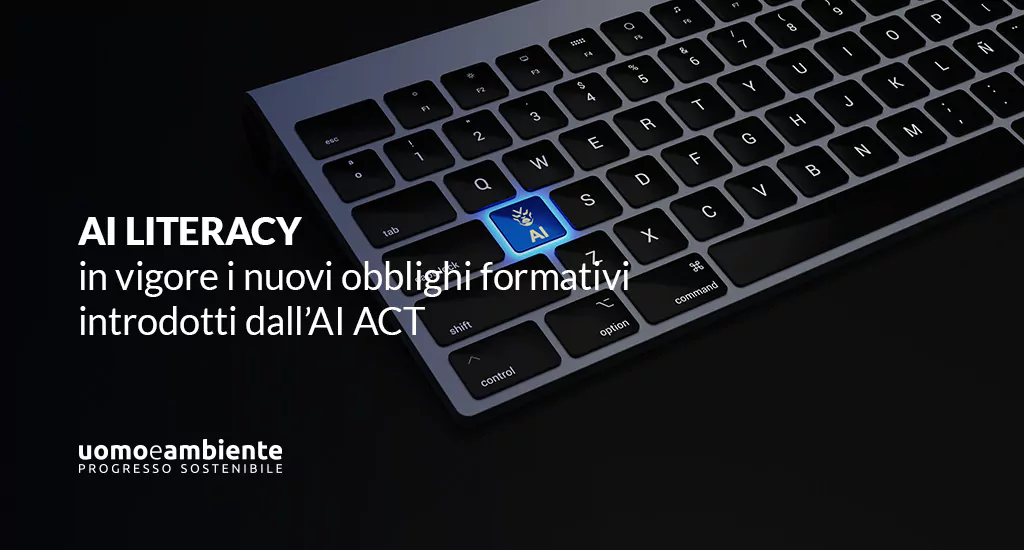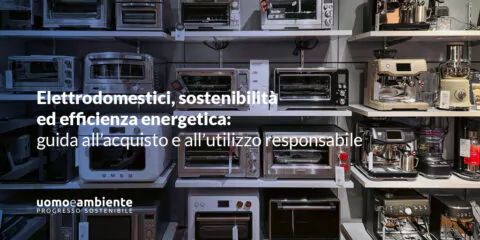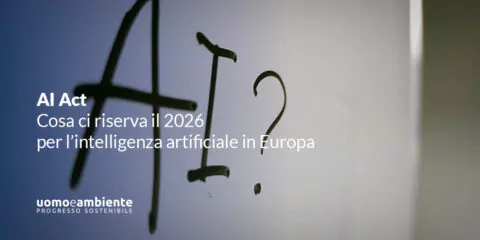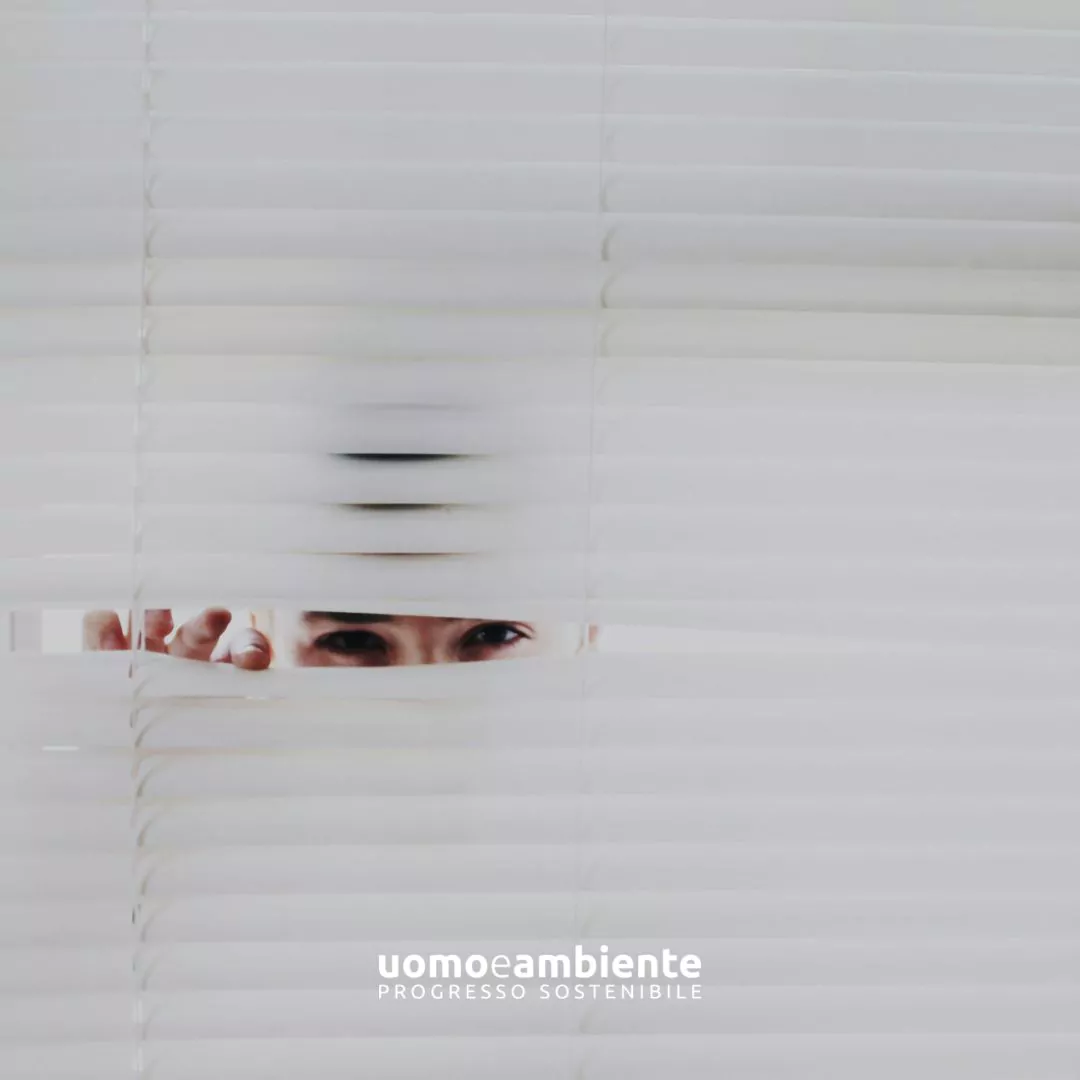AI literacy è una competenza indispensabile in azienda. L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante di molti ambiti della nostra vita, dalla sanità alla finanza, fino all’uso quotidiano. Per questo, saper comprendere e interagire consapevolmente con l’AI non è più una competenza riservata a tecnici e sviluppatori, ma una necessità per tutti.
Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, introduce l’obbligo per organizzazioni pubbliche e private di attivare percorsi formativi sull’AI Literacy, ovvero l’alfabetizzazione all’AI.
Che cos’è l’AI Literacy
Ma cosa si intende esattamente per AI Literacy? Secondo l’AI Act, è l’insieme di conoscenze, competenze e consapevolezza che permette di comprendere il funzionamento, le potenzialità e i rischi dell’AI, inclusi quelli etici, legali e sociali. Non basta saper usare strumenti come ChatGPT per generare contenuti: serve anche capire come utilizzarli responsabilmente. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che fornitori e utilizzatori di sistemi AI devono adottare misure per garantire un 'livello sufficiente' di alfabetizzazione tra tutti coloro che interagiscono con questi strumenti: non solo dipendenti, ma anche collaboratori, clienti e partner.
Formazione su misura e approccio basato sul rischio
Quando si progettano attività di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale, non esiste un approccio unico, valido per tutti. Le iniziative formative devono essere costruite su misura, tenendo conto di variabili come il livello tecnico, l’esperienza, l’istruzione e il contesto in cui l’AI viene utilizzata. Organizzazioni pubbliche e private dovranno quindi adattare i programmi formativi al proprio contesto operativo, valutando, ad esempio, il tipo di sistema impiegato o i ruoli delle persone coinvolte. Tutto ciò è in linea con il principio del “risk-based approach” previsto dall’AI Act, che impone di modulare l’alfabetizzazione in base al rischio potenziale del sistema. Ad esempio, l’uso di una chatbot per il customer service richiederà un livello di preparazione diverso rispetto a un sistema di valutazione del credito.
Il regolamento non impone un formato rigido per la formazione: ogni organizzazione può scegliere le modalità più adatte (workshop, corsi online, moduli interattivi, ecc.). Tuttavia, è essenziale documentare tutte le iniziative formative, che dovrebbero coprire almeno:
- la comprensione generale dei sistemi di AI,
- il ruolo dell’organizzazione nell’utilizzo dell’AI,
- la valutazione dei rischi,
- i riferimenti normativi e i principi etici dell’AI Act.
Anche se l’approccio è proporzionale al rischio, ignorare completamente l’obbligo di AI Literacy può comportare sanzioni, secondo le leggi nazionali che entreranno in vigore entro il 2 agosto 2025. In caso di malfunzionamenti o errori causati da una scarsa preparazione o da una carenza formativa, la responsabilità potrà ricadere direttamente sull’organizzazione.
È quindi essenziale muoversi già ora per evitare rischi futuri. Ma l’AI Literacy non è solo un obbligo normativo: è una leva strategica. Chi oggi investe nella cultura e nella formazione sull’intelligenza artificiale sarà domani più pronto ad affrontare l’innovazione, tutelare i propri utenti e ridurre rischi legali, reputazionali ed economici.
L’alfabetizzazione all’AI, infatti, non è una semplice opzione, ma parte di una più ampia responsabilità civica nel mondo digitale. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) è chiaro: servono documentazione trasparente, sorveglianza umana, robustezza tecnica. Ma la posta in gioco va oltre la conformità. Si tratta di governare l’AI in modo etico quando si prendono decisioni che impattano il futuro delle persone.
L’AI entra in azienda… anche senza invito
L’intelligenza artificiale è ormai arrivata in azienda. Ma non sempre passando dalla porta principale. Oggi l’AI viene usata per selezionare, valutare, monitorare e perfino licenziare le persone. È già realtà in molti ambienti di lavoro. Dietro l’efficienza promessa, però, si cela un rischio profondo: delegare agli algoritmi decisioni che toccano diritti fondamentali.
Questi sistemi non si limitano ad analizzare dati: influenzano vite, modellano percorsi, decidono opportunità.
Quando l’AI incide sulla dignità delle persone, entrano in gioco obblighi stringenti:
- sorveglianza umana,
- trasparenza,
- sicurezza,
- accountability.
Perché non si tratta solo di tecnologia, ma di responsabilità sociale ed etica.
Tra le normative giuridiche e la realtà operativa delle organizzazioni, si creano delle crepe. L'AI Act, il GDPR e la NIS 2 impongono obblighi distinti ma intrecciati: trasparenza algoritmica, protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Tuttavia, nel concreto, queste normative rischiano di restare compartimenti stagni, creando tre principali problematiche che minano la compliance:
- Sovrapposizione normativa
- Governance assente
- Sicurezza trascurata
Un metodo per governare la tecnologia
Se ignorate, queste problematiche trasformano l'adozione dell'AI da opportunità strategica a rischio sistemico. Per applicare l'AI Act in modo efficace, non bastano policy generiche o audit formali. Serve un approccio operativo, multidisciplinare e documentato. I sette passaggi che seguono offrono una chiara traccia per una compliance che integri etica, diritto, sicurezza e governance. Perché solo chi ha un metodo può davvero governare la tecnologia.
- Mappare e classificare: ogni sistema di AI va identificato e tracciato. È fondamentale avere chiari obiettivi, base giuridica, dati trattati, soggetti coinvolti e livello di rischio. Senza consapevolezza, non ci può essere né difesa né regolazione.
- Integrare GDPR e AI Act: le valutazioni separate non bastano. Serve un’analisi integrata che unisca tutele dei diritti, requisiti tecnici, sorveglianza umana, impatti etici e misure di mitigazione previste da entrambe le normative.
- Attivare la governance fin dall’inizio: DPO, HR, LEGAL, CISO e IT devono essere coinvolti fin dalla fase progettuale. I ruoli, le responsabilità e i controlli devono essere formalizzati dal principio.
- Garantire una supervisione umana significativa: l’intervento umano deve essere reale, tempestivo e consapevole. Non basta la presenza formale: serve la possibilità concreta di correggere, bloccare e intervenire, altrimenti il sistema è insostenibile legalmente.
- Applicare la cybersecurity by design: audit trail, controlli d’accesso, monitoraggio continuo, resilienza ai data poisoning: ogni AI è un asset digitale da trattare come infrastruttura critica.
- Informare e coinvolgere i lavoratori: trasparenza radicale: informazioni chiare, accessibili e preventive. È fondamentale coinvolgere le rappresentanze e garantire i diritti dei lavoratori, come base per un rapporto di lavoro solido e sostenibile.
- Costruire l’AI Compliance File: serve un fascicolo tecnico-giuridico aggiornato che documenti la progettazione, i test, gli audit, i controlli e le misure attuate. È il cuore dell’accountability.
La vera innovazione non è solo nel "cosa", ma nel "come". L’AI Act ci chiede di governare l’intelligenza artificiale con consapevolezza. Ogni algoritmo è una leva di potere che agisce sulle persone, guida decisioni e genera impatti. Non basta applicare le regole in automatico. Serve un metodo solido, documentato e condiviso, che integri innovazione e responsabilità. Solo così l'AI potrà davvero creare valore.
Come UOMOeAMBIENTE può supportarti
UOMOeAMBIENTE affianca organizzazioni pubbliche e private nella costruzione di un percorso solido di AI literacy e compliance. Offriamo:
- SCREENING: supporto operativo per mappare, classificare e valutare i sistemi di AI.
- PROGETTAZIONE: definizione di percorsi formativi su misura per dipendenti, dirigenti e stakeholder.
- INTEGRAZIONE: applicazione dell'AI Act, da integrare a GDPR e NIS2, strumenti che costituiscono pilastri solidi nella governance delle organizzazioni.
Con un approccio multidisciplinare e operativo, aiutiamo le organizzazioni a trasformare un obbligo normativo in un vantaggio competitivo fondato sull’etica, la sicurezza e l’innovazione.